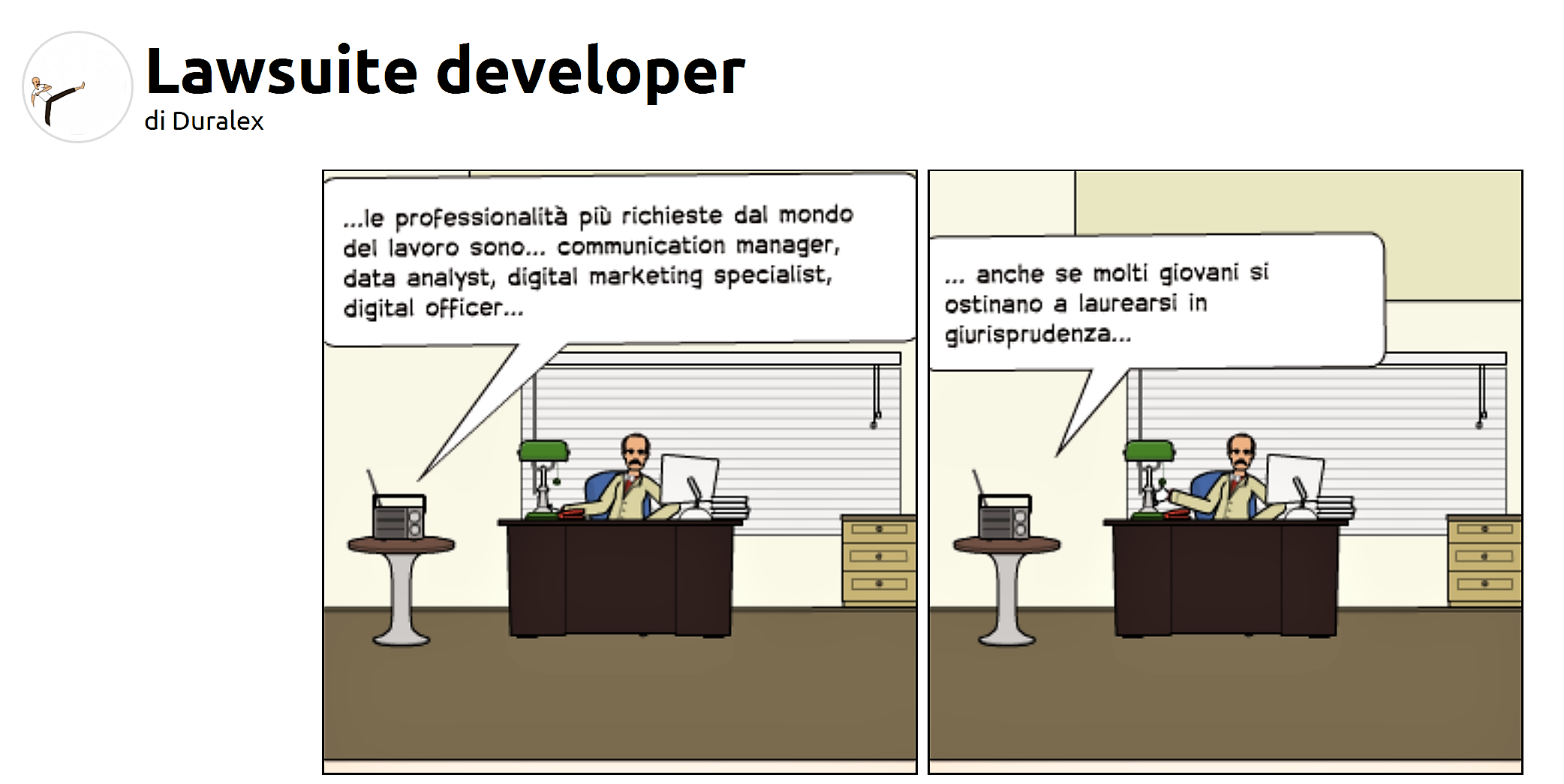Consorzio fra imprese: quando la società consortile rende prestazioni nei confronti dei terzi, la rifatturazione da parte delle consorziate non segue una regola fissa ma dipende dalla natura del rapporto interno
Il consorzio (art. 2602 c.c.), nella sua forma più semplice, si basa su un contratto associativo con il quale più imprenditori disciplinano in modo uniforme alcune fasi produttive delle rispettive aziende (consorzi ad attività interna). Per esempio le attività volte a salvaguardare in modo omogeneo lo standard qualitativo di determinati prodotti di pregio.
In altri casi, invece, gli imprenditori consorziati creano un nuovo soggetto – spesso una società consortile di capitali – la quale è deputata a portare avanti, in nome proprio ma nell’interesse delle imprese consorziate, una o più fasi dei rispettivi processi produttivi, come lavorazioni, trasporti, servizi tecnici, ecc.
Si assiste quindi al fenomeno di un società consortile, partecipata da più società consorziate.
In sostanza, si utilizza la logica del gruppo, secondo quel concetto, ben noto al capitalismo contemporaneo, di “spacchettamento” fra più soggetti formalmente autonomi di un’unica impresa, intesa in senso economico.
I consorzi di questo tipo operano nel mercato come se fossero delle imprese autonome ma lo fanno con finalità mutualistica, in quanto il loro scopo non è la realizzazione di un utile da dividere tra i soci (consorziati), bensì quello di consentire a costoro il conseguimento di un vantaggio, sub specie di risparmio nei costi di produzione o di aumento dei ricavi generati dalle rispettive imprese.
La finalità mutualistica della società consortile non le impedisce, però, di ricavare dal mercato i mezzi per il proprio sostentamento, secondo quella logica, propria del moderno diritto dell’economia, per la quale mutualità non vuol dire necessariamente assenza di ricavi o mancanza di economicità di gestione e di imprenditorialità dell’azione.
I mezzi necessari per far fronte al funzionamento del consorzio, possono perciò essere reperiti in modi diversi, per esempio facendo pagare ai consorziati un corrispettivo a fronte dei servizi consortili oppure trattenendo una percentuale sulle vendite effettuate per loro conto o, ancora, fatturando direttamente ai terzi committenti, con un ricarico, le prestazioni che materialmente saranno eseguite da una o più consorziate.
In considerazione delle molteplici modalità operative appena esemplificate, appare chiaro che, quando si rende necessario valutare le conseguenze giuridiche di una determinata prestazione resa dal consorzio, occorre ricostruire la sostanza dell’operazione, alla luce della natura del fenomeno consortile e dei rapporti intercorrenti, nel caso concreto, fra la società consortile e le singole consorziate, che con la prima hanno interagito.
La mancata considerazione di tutto ciò ha spesso condotto ad un approdo interpretativo erroneo e del tutto superficiale, in cui l’analisi della singola prestazione è stata considerata in modo impropriamente atomistico.
Una delle più autorevoli e recenti ricostruzioni della fenomenologia consortile fin qui descritta è stata operata da Cassazione SS.UU. nn. 12190 e 12191 del 2016.
Nel caso esaminato dalla Corte, il Consorzio aveva emesso, nei confronti della committente, una fattura maggiorata rispetto a quella emessa nei suoi confronti dalla consorziata che aveva eseguito materialmente l’appalto.
Attraverso questo ricarico, il Consorzio aveva inteso trasferire sul prezzo pagato dal terzo committente i propri costi di funzionamento, che, altrimenti, sarebbero andati a gravare sulle imprese consorziate.
La sentenza, nel ribadire l’importanza di una disamina in concreto delle ragioni che, nel singolo rapporto, hanno determinato la differenza di fatturazione, enumera le evenienze che possono verificarsi in proposito.
Il minore importo fatturato al Consorzio dalla consorziata che esegue la prestazione può essere giustificato da una ripartizione di costi generali di gestione o da un addebito di costi specifici, legati alla singola commessa. Può essere dovuto al pagamento di provvigioni, da parte della consorziata, per il procacciamento dell’affare o, infine, costituire il corrispettivo delle prestazioni che il Consorzio ha fornito al committente in aggiunta e a completamento di quelle fornite dalla consorziata.
Ne discende che, per qualsiasi effetto, compresi quelli di ordine fiscale, sarà indispensabile operare una corretta e puntuale ricostruzione della natura delle commesse, al fine di appurare le ragioni poste a base della differenza di fatturazione.
La sentenza in commento si è occupata espressamente della problematica di ordine fiscale, relativa al corretto ammontare della fatturazione cui è tenuta la consorziata nei confronti del consorzio.
La pronuncia però, nella parte in cui prende espressa posizione in ordine alla questione, controversa, della corretta ricostruzione della natura delle società consortili, compone un mosaico in cui le tessere della mutualità si fondono armonicamente con quelle dello svolgimento di autonoma attività lucrativa, dettando un importante principio di diritto.
Afferma che “La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l’accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata … nell’esecuzione delle commesse”.
E ancora, viene precisato che la società consortile ben può realizzare autonomi ricavi, nascenti dalla rifatturazione, con ricarico, delle prestazioni eseguite in favore del committente da parte di una società consorziata.
Tali principi possono e devono trovare applicazione anche in controversie diverse da quelle afferenti agli accertamenti fiscali sui ricavi delle consorziate.
Essi devono costituire lo scenario di riferimento normativo anche per i casi ove venga sottoposto a scrutinio giudiziario il comportamento tributario non già della consorziata ma del terzo committente, addebitando a costui la circostanza di aver ricevuto la fatturazione direttamente dalla società consortile.
In particolare, attesa la appena richiamata complessità dei rapporti potenzialmente intercorrenti fra società consortile e consorziate, non sarà sufficiente, in tema di riscontro delle fatture inserite in contabilità, dedurre puramente e semplicemente, in danno del committente, una mancata coincidenza fra società consortile che ha emesso la fattura e società consorziata che ha eseguito la parte più qualificante della prestazione fatturata.
Sarà per contro indispensabile, ove si voglia legittimare la piattaforma sanzionatoria tributaria o penal-tributaria, dimostrare in modo puntuale per quali ragioni nel caso concreto – e con riferimento alla condizione sia oggettiva che soggettiva del terzo committente – non dovrebbe poter operare il meccanismo di rifatturazione descritto dalle Sezioni Unite e fin qui commentato.
Autore dell’articolo Enrico Leo – maggio 2017
Bancarotta per distrazione: la nuova frontiera richiede che l’atto distrattivo presenti, già al momento della sua esecuzione, una concreta e riconoscibile attitudine a diminuire il patrimonio in modo pericoloso per le ragioni creditorie
Nuova tappa nel tormentato cammino che la Cassazione ha intrapreso da anni, con molti tentennamenti e dietro front, per dare alla bancarotta un profilo più umano, vale a dire più rispettoso del divieto di responsabilità penale oggettiva o di ruolo.
Il problema nasce da quella giurisprudenza, molto diffusa, la quale afferma che qualsiasi atto di diminuzione del patrimonio costituisce bancarotta in caso di successivo fallimento. Anche se tale fallimento intervenga a distanza di molti anni e anche se lo stesso non fosse minimamente prevedibile al momento del compimento dell’azione. Insomma, se vendi a cinque un bene che vale dieci, provochi una diminuzione patrimoniale netta e devi solo sperare di non fallire, poiché se interviene il fallimento, anche a distanza di molti anni e anche per ragioni del tutto indipendenti dalla svendita appena esemplificata, puoi rispondere di bancarotta.
Sul punto il caso Parmalat ha fatto scuola (in senso fortemente negativo per gli imputati), visto che sono state comminate condanne anche per fatti depauperatori posti in essere nel 1992, pur essendo intervenuto il fallimento solo nel 2004.
La sentenza 17819, depositata qualche giorno fa, nel tentativo di farsi carico di questa problematica, esprime i principi che qui di seguito si riassumono.
- Nessun problema si pone per quei comportamenti posti in essere in prossimità, cronologica e patrimoniale, dello stato di insolvenza (cosiddetta “zona di rischio penale”) in quanto per essi appare in tutta evidenza l’esistenza e l’accertabilità di un concreto pericolo per le ragioni dei creditori.
- Poiché i concetti di prossimità cronologica e patrimoniale sono elastici, occorre valutare attentamente le ipotesi dubbie. Su di esse si incentra l’elaborazione del criterio di discernimento proposto dalla Corte.
- L’analisi dell’atto incriminato deve essere condotta con riferimento sia alla sua oggettiva destinazione funzionale, sia alla consapevolezza che di tale destinazione potesse avere il soggetto agente. Per entrambi gli aspetti deve valere il criterio che l’accertamento va condotto “ex ante”, vale a dire sulla base del punto di vista che poteva essere disponibile al momento della sua implementazione e non invece sulla base di quanto sarebbe emerso solo in seguito.
- In particolare, ciò che conta è la situazione patrimoniale e finanziaria al momento del compimento dell’atto e non quella frutto, ad esempio, di un successivo tracollo economico non imputabile al soggetto agente.
- In sostanza, anche senza arrivare a sposare la teoria che vorrebbe l’esistenza di un vero e proprio nesso di causalità fra l’atto e il dissesto, si arriva oggi a dire che manca un elemento di addebitabilità, quantomeno soggettiva, in quei casi in cui non appaia evidente e non si riesca a dimostrare che al momento dell’atto, ed a causa di questo, si era già venuta a determinare una riconoscibile situazione di pericolo per il soddisfacimento degli interessi dei creditori.
- L’introduzione del requisito della congruenza dell’azione rispetto alla messa in pericolo del bene protetto dalla norma, vale a dire del soddisfacimento dei diritti dei creditori, e soprattutto della permanenza di tale congruenza fino alla declaratoria di fallimento, vale ad escludere dall’area di punibilità quelle condotte che, rientrando nel fisiologico azzardo imprenditoriale, apparivano giustificate dal fatto che, in quel momento, il successivo tracollo non era ragionevolmente prevedibile quale conseguenza dell’atto.
Resta da aggiungere che la sentenza appena commentata non solo non risolverà tutte le incertezze ma, ragionevolmente, ne produrrà di ulteriori. Essa, però, ha il pregio di porre l’accento sulla valutazione “ex ante” dell’elemento soggettivo che ha accompagnato l’esecuzione dell’atto.
E’ noto, infatti, che i comportamenti rispetto ai quali occorrere aggiungere chiarezza, a beneficio del sistema economico, sono quelli in cui l’imprenditore assume il rischio di diminuire il patrimonio ma lo fa quale inevitabile conseguenza del mestiere che ha scelto, vale a dire l’assunzione del rischio.
Gli altri, punibili, sono quelli che, a prescindere dal momento in cui vengono realizzati, comportano una coessenziale diminuzione del patrimonio, la quale appare fin da subito priva di qualsiasi giustificazione pertinente al merito imprenditoriale.
Non di rado i giudici confondono i due piani e assumono pronunce che penalizzano il merito manageriale, con un’impropria invasione di campo, la quale tende a giudicare ex post, sul presupposto dell’intervenuto depauperamento, azioni di impresa che presentano il solo difetto di non essere riuscite nel loro intento.
Autore Enrico Leo – aprile 2017
Nuove regole per la responsabilità penale e civile dei medici
Approvato in via definitiva il disegno di legge Gelli che modifica il regime di responsabilità, sia penale che civile, degli esercenti le professioni sanitarie.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si prevede che, ove l’evento di morte o lesioni sia stato causato da imperizia, sia per colpa grave che per colpa lieve, la punibilità sia esclusa, a patto che siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di specifica linea guida, le buone pratiche clinico assistenziali.
Tutto ciò a meno che il caso concreto non presenti delle specificità tali da rendere inadeguata l’applicazione delle stesse linee guida.
La nuova norma, dunque, sembrerebbe escludere dalla sua area operativa i casi di negligenza, per i quali non vale l’esclusione di punibilità. Questa distinzione sarà fonte di non poche incertezze nelle aule giudiziarie, visto che, nei casi concreti, è quasi sempre difficile separare nettamente la negligenza dall’imperizia.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità civile, i medici potranno operare con molta maggiore tranquillità. E’ infatti previsto non soltanto che l’azione civile, ove proposta direttamente nei loro confronti, si debba informare ai canoni, ben più difficoltosi sotto il profilo probatorio, della responsabilità extracontrattuale.
E’ altresì previsto che l’eventuale azione risarcitoria debba essere preceduta da un accertamento tecnico preventivo, con tentativo di conciliazione. Ancora, si è previsto che l’eventuale azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero nei confronti del sanitario, possa essere esperita solo a seguito dell’ effettivo avvenuto risarcimento e, cosa più importante, è stato posto un tetto massimo oltre il quale il medico non dovrà sopportare le conseguenze economiche del sinistro.
In ogni caso l’ente ospedaliero è obbligato ad assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale gravante sulla struttura, sia per la copertura della responsabilità extracontrattuale dei medici che vi operano, per l’ipotesi in cui il danneggiato decida di esperire l’azione risarcitoria direttamente nei loro confronti.
Autore dell’articolo Enrico Leo
Difesa outlet ?
Esistono alcuni siti internet che si occupano di segnalare, a chi sia alla ricerca di un avvocato, lo studio che, per un determinato tipo di causa, pratica il prezzo più basso.
In altri termini, tali siti, dopo aver raccolto il “tariffario” di quegli avvocati che intendono aderire all’iniziativa, eseguono una comparazione basata, a quanto pare, unicamente sul prezzo.
Gli avvocati che aderiscono allo schema e chiedono di essere segnalati con queste modalità, potrebbero trovarsi a fronteggiare un procedimento disciplinare.
Ma, prescindendo da ciò, è bene riflettere sull’effetto che questo tipo di offerta pubblicitaria determina sul soggetto che ha necessità di tutelare un proprio diritto e, più in generale, sul consumatore.
La comparazione “secca” sul prezzo ha un senso, in termini di aiuto al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa, solo quando avvenga fra prodotti identici.
Fra due lattine di birra della stessa marca sembra ovvio scegliere quella che costa di meno.
Quando però non si tratta di prodotti finiti e comparabili ma di prestazioni, le quali, per loro natura, non sono suscettibili di arrivare ad un risultato certo e predeterminato, allora la situazione si complica.
Se, per esempio, devo essere difeso in in processo penale delicato, in cui è importante uno studio accurato delle carte processuali, un’esperienza concreta fatta di anni di lavoro, un approccio autorevole con il giudice, un eloquio puntuale e deciso, allora il costo del professionista non può essere l’elemento prioritario e determinante. Scegliere un professionista a caso, basandosi solo sul prezzo richiesto, potrebbe voler dire ottenere un risultato qualitativamente molto peggiore di quello che ci avrebbe fatto ottenere un avvocato diverso.
A questo si aggiunga che, anche per gli avvocati, il fattore tempo è uno dei parametri di cui si deve tener conto nel calcolo della parcella. Nella soluzione della maggior parte dei casi legali, infatti, il tempo dedicato al fascicolo costituisce un elemento determinante.
Vale a dire che più tempo si dedica alla preparazione della difesa e migliore è il risultato che si ottiene. Per contro, meno si paga, meno tempo ci può essere dedicato.
Autore dell’articolo Enrico Leo
Avvocati generalisti, avanti tutta?
In tutti i settori dell’economia la specializzazione del lavoro è considerata unanimemente un fattore irrinunciabile di efficentizzazione del sistema. Doveva essere così anche per le professioni ma, per ciò che riguarda l’Avvocatura, la crisi dell’economia e del sistema giustizia, negli ultimi anni, ha prodotto un deciso arresto, con successiva retromarcia.
Le cause sono principalmente tre: enorme numero di avvocati, crisi economica generale, inefficienza della macchina della giustizia.
Il sistema giuridizionale non funziona. Qualsiasi cittadino che ne resti coinvolto, finisce per pensare che avere giustizia sia una specie di terno al lotto. E allora o si evita di imbarcarsi nell’impresa o, se proprio non se ne può fare a meno, si cerca di spendere il meno possibile per l’avvocato. Tanto uno vale l’altro.
La crisi economica accelera e favorisce questo atteggiamento, visto che, quando i soldi sono pochi, si ricorre all’hard discount.
L’enorme numero di avvocati fa da deflagrante. Coloro che giungono ad indossare la toga hanno pur bisogno di guadagnare e, per farsi spazio nel mondo affollato della professione, non trovano nulla di meglio che assumere qualsiasi incarico gli si prospetti, saltando dal civile al penale, all’amministrativo e passando per tutte le specializzazioni interne a ciascuna di queste macro aree.
In questo modo, moderni servi della gleba si sforzano di apparire competenti in qualsiasi settore del diritto. Lavorano giorno e notte per poter mettere insieme quel minimo di cognizioni necessarie a portare avanti i più disparati incarichi che sono riusciti a raggranellare. Guadagnano poco, soprattutto se quel poco è messo a confronto con l’enorme mole di lavoro e di sacrificio e con la responsabilità professionale che si assumono.
Così facendo, gli avvocati contribuiscono a sminuire la già magra considerazione sociale di cui godono.
Accettando corrispettivi inappropriati, innescano una corsa al ribasso delle tariffe e, con essa, la banalizzazione e lo svilimento del lavoro professionale.
Ogni tanto qualcuno di loro alza la testa, inizia a pensare che il gioco non valga la candela e cerca di costruirsi un’alternativa al di fuori della professione forense.
Eppure la risposta più saggia per coloro che possono permetterselo è quella di continuare a coltivare una competenza specifica e approfondita. Un posizionamento chiaro e preciso nel mercato dei servizi legali alla fine intercetterà l’onda lunga dei clienti migliori e delle scelte strategiche che perseguono un obiettivo posto al di là delle contingenze e delle congiunture.
Autore dell’articolo Enrico Leo
Fondo patrimoniale e intestazioni di beni a terzi: l’imputato si salva dal sequestro solo a determinate condizioni
Com’è noto, il Pubblico Ministero e la parte civile possono chiedere al giudice il sequestro conservativo dei beni dell’imputato, soprattutto per “bloccare” risorse utili ai fini del risarcimento del danno causato dal reato.
Per esempio, in caso di bancarotta o di reato tributario, viene richiesto il sequestro dei beni dell’amministratore della società responsabile del crack o della fraudolenta evasione di imposta.
Questi sono i principali casi che possono presentarsi:
– trattandosi di fondo patrimoniale, oltre a quanto si dirà in seguito con riferimento agli atti a titolo gratuito, occorre considerare che la legge salvaguarda i beni del fondo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, la qual cosa può porre dubbi interpretativi quando si ha a che fare con obbligazioni risarcitorie che nascono da alcuni tipi di reato, come ad esempio quelli tributari, visto che in simili ipotesi non è sempre facile verificare l’estraneità ai bisogni familiari dell’obbligazione rimasta inadempiuta;
– trattandosi, invece, di polizza assicurativa sulla vita, occorre verificarne la natura di strumento previdenziale o, per contro, di strumento finanziario;
– in ogni altro, caso occorre verificare la pignorabilità dei beni o diritti che si intende sottoporre a sequestro, secondo le regole civilistiche valide per specifiche categorie di beni o rapporti;
– quando i beni di cui si chiede il “blocco” sono formalmente intestati a terzi, è poi necessario verificare la natura dell’atto con cui detti terzi li hanno acquisiti, al fine di accertare se la formale intestazione sia da considerare inefficace rispetto al sequestro o, viceversa, possa validamente arginarlo. A questo proposito si possono indicare:
● atti dispositivi a titolo gratuito compiuti dall’imputato dopo la commissione del reato, i quali sono sempre travolti dal sequestro;
● atti a titolo gratuito compiuti nell’anno precedente la commissione del reato, i quali sono travolti dal sequestro se si prova l’intento frodatorio;
● atti a titolo gratuito o oneroso compiuti in epoca risalente a più di un anno prima della commissione del reato, che non sono mai travolti dal sequestro;
● atti a titolo oneroso eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dall’imputato dopo la commissione del reato, i quali sono travolti dal sequestro se si prova la mala fede dell’acquirente;
● atti a titolo oneroso eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dall’imputato in epoca risalente a non più di un anno prima della commissione del reato, i quali sono travolti dal sequestro se si prova la mala fede sia dell’imputato che dell’acquirente;
● atti rientranti nel disposto dell’art. 64 legge fallimentare, con riferimento ai reati previsti dalla medesima legge.
In tutte le predette ipotesi, che rientrano nel concetto di revocatoria penale, l’accertamento dei fatti che legittimano l’apprensione del bene intestato a terzi ed il suo utilizzo per pagare il risarcimento del danno causato dall’imputato o per gli altri fini di giustizia penale, avviene in sede penale e trova il suo terreno d’elezione proprio al momento della richiesta di sequestro.
Ne deriva la necessità, sia per la parte civile che per la difesa dell’imputato, di introdurre nel processo elementi probatori idonei a sostenere la sequestrabilità di determinati beni o, viceversa, la loro intangibilità.
Considerando che, accanto alle statuizioni sulla libertà personale, l’odierno processo penale si occupa di rilevanti questioni economiche legate al reato e che, molto spesso, queste ultime colpiscono prima e più duramente delle prime, si rende indispensabile preparare per tempo una difesa efficace anche con riferimento agli aspetti patrimoniali fin qui richiamati.
Autore dell’articolo Enrico Leo – tutti i diritti riservati
Per approfondimenti invia una email
Le linee guida escludono la condanna del sanitario sia con riferimento alla valutazione della diligenza che della perizia
Continua il lavoro interpretativo della Cassazione penale sulla portata della legge Balduzzi, che ha depenalizzato le condotte dei sanitari connotate da colpa lieve, introducendo un inedito nel nostro sistema penale, vale a dire il discrimine, ai fini della punibilità, fra colpa grave e colpa lieve.
Alcuni principi possono dirsi ad oggi abbastanza sedimentati.
In linea generale, la nuova normativa impone che l’azione penale incardinata contro il sanitario si misuri con due fondamentali temi di accertamento: se l’azione del medico si sia sviluppata all’interno di linee guida diagnostico terapeutiche; se la stessa, pur rimanendo in tale perimetro, abbia assunto profili di colpa lieve. In presenza di queste due caratteristiche, il sanitario sarà prosciolto.
Tali verifiche dovranno essere eseguite già dal pubblico ministero in fase di indagini preliminari e, in ipotesi di rinvio a giudizio, il capo di imputazione dovrà contenere l’esplicita menzione dei risultati. Il Pm, cioè, dovrà formulare un’accusa che dimostri sia la divergenza del comportamento concretamente tenuto dalle linee guida, sia il livello della colpa, misurato in riferimento alle specifiche circostanze in cui il medico si è trovato ad operare.
Quanto, in particolare, alla natura delle linee guida, queste sono identificabili come raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate attraverso la disamina sistematica della letteratura scientifica, al fine di aiutare il personale sanitario a decidere le modalita assistenziali piu appropriate, in riferimento a situazioni cliniche tipizzate.
Esse sono per lo più volte a ridurre la soggettivizzazione dei comportamenti clinici con riferimento alla medesima situazione e, pertanto, presuppongono che il sanitario possa trovarsi di fronte ad una scelta fra due alternative diagnostiche o terapeutiche, da lui ritenute astrattamente praticabili, sebbene ciascuna con le proprie controindicazioni o, se si vuole, con il proprio margine di rischio. In simili alternative, il sanitario che vorrà ridurre l’alea legata a possibili conseguenze penali della propria condotta, dovrà scegliere l’opzione suggerita dalla pertinente linea guida. Così facendo egli non eliminerà ogni ulteriore margine di scelta, in quanto dovrà comunque operare secondo scienza e coscienza nel far aderire la raccomandazione alle molteplici specificità del caso concreto. Limiterà però il pericolo di incorrere in responsabilità poichè, nella suddetta discrezionalità di dettaglio, gli verranno scusate eventuali azioni connotate da colpa lieve.
Resta da capire se l’esimente in commento possa operare solo con riferimento ai casi di imperizia o anche a quelli di negligenza, con la precisazione che nella pratica giudiziaria appare piuttosto arduo incontrare vicende che presentino, con riferimento alla condotta concreta oggetto di incriminazione, una netta differenziazione fra i due profili di addebito.
E’ da dire, innanzi tutto, che non può escludersi che le linee guida pongano canoni rispetto ai quali il parametro valutativo della condotta sia quello della diligenza, come, per esempio, il rispetto di una procedura basata sulla pedissequa osservanza di una sequela di azioni di carattere più materiale che clinico. La nuova legge, peraltro, non si riferisce solo ai medici ma anche, ad esempio, al personale infermieristico, categoria spesso onerata di comportamenti da valutare più sotto il profilo della diligenza esecutiva che non sotto quello della corretta soluzione di quesiti di complessa natura intellettuale.
In sostanza, la valutazione della scriminante deve operare sia sul versante della diligenza che su quello della perizia, posto che il giudice, nella verifica della colpa, deve tenere conto unicamente del livello, maggiore o minore, di scostamento della condotta tenuta da quella che ci si poteva attendere sulla base della raccomandazione professionale di riferimento.
Autore dell’articolo Enrico Leo – tutti i diritti riservati
Il fallito può mentire al curatore? Obbligo di verità, facoltà di mentire e pericolo di autoincriminazione: tre possibili prospettive delle dichiarazioni rese agli organi fallimentari
Il fallito, vale a dire l’imprenditore individuale o il legale rappresentante della società fallita, viene ben presto a contatto con il curatore, il quale gli formula svariate domande. Le principali sono quelle destinate a conoscere la consistenza dell’attivo e la presenza di beni da poter utilmente liquidare, come pure quelle volte a ricostruire le cause del dissesto e quelle destinate ad eventuali chiarimenti di ordine contabile.
In questa fase, il fallito manifesta una comprensibile tendenza a intavolare un buon rapporto con il curatore e non sempre è in grado di rendersi conto della portata delle dichiarazioni che rende a verbale. Soprattutto se non accompagnato e adeguatamente assistito da un professionista con specifica formazione in materia.
Su alcune questioni il fallito non può mentire, in quanto esistono delle norme che gli impongono di dire la verità, stabilendo sanzioni penali per la trasgressione.
Parliamo innanzi tutto dell’art. 87 della legge fallimentare, il cui terzo comma dispone che, in sede di redazione dell’inventario il curatore invita il fallito a dichiarare se vi siano ulteriori attività fino a quel momento non appalesate, avvertendolo delle pene stabilite dall’articolo 220 della stessa legge, per il caso di falsa o omessa dichiarazione.
Su questo aspetto, il fallito non può dunque tenere un comportamento omissivo o reticente, poiché ne conseguirebbe un’incriminazione, a titolo doloso o anche colposo.
In realtà, nella prassi dei tribunali è molto raro incontrare un capo di imputazione di questo tipo, in quanto la mancata indicazione di beni viene sempre assorbita nel ben più grave reato di bancarotta per distrazione e anzi ne costituisce una delle più ricorrenti tecniche incriminatorie.
Ne consegue che è proprio con quest’ultima evenienza che il fallito deve fare i conti, allorchè si tratti di decidere quale debba essere il contenuto delle dichiarazioni da rendere al curatore.
L’imputazione di bancarotta per distrazione, sotto il profilo probatorio, si sviluppa attraverso quella peculiarità del diritto penale fallimentare che viene indicata come un’apparente inversione dell’onere della prova.
E’ la giurisprudenza a sottolineare che, in realtà, l’inversione dell’onere della prova è solo apparente e ciò consente che, in questi casi, vengano comminate condanne nel rispetto della presunzione costituzionale di non colpevolezza che, com’è noto, spetta all’accusa di ribaltare.
In sostanza, la mancata indicazione di un bene e la mancata dimostrazione del motivo per il quale lo stesso non è stato consegnato al curatore, sono comportamenti dai quali può essere desunta la prova della distrazione. E ciò anche in forza del fatto che l’art. 87, comma 3, del R.D. n. 267/1942 assegna al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni d’impresa. Ne consegue che, ai fini della prova della distrazione, assume rilievo la condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello. Non si tratta, dunque, di inversione dell’onere delle prova ma, invece, del rilievo indiziario di un contegno reticente.
Al di fuori del caso appena descritto, che si riferisce in modo specifico al dovere di dire la verità in ordine ai cespiti patrimoniali e alle conseguenze che la reticenza può comportare in ordine alla configurazione del reato di bancarotta per distrazione, esiste però un’area molto ampia di argomenti rispetto alla quale il fallito non ha un obbligo specifico di dire al curatore la verità.
Cosa accade ad esempio se un fallito dichiara falsamente, al curatore e alla polizia giudiziaria, che le scritture contabili sono andate distrutte a seguito di un allagamento ?
Nulla di penalmente rilevante.
Infatti, secondo recente giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) sussiste solo qualora l’atto pubblico che recepisce la dichiarazione del privato, sia ontologicamente preordinato a costituire prova della verità dei fatti narrati. Vale a dire che vi deve essere una norma giuridica che ricolleghi alla dichiarazione la specifica funzione di costituire prova della verità dei fatti che ne costituiscono l’oggetto. Ciò non accade per la dichiarazione resa dal fallito, la quale, per il solo fatto di essere recepita nel verbale del curatore, non diventa prova privilegiata della veridicità degli accadimenti.
In sostanza, ciò che il fallito dichiara, anche se a lui favorevole, non gli può giovare se non nel quadro e alla stregua di qualsiasi altro elemento raccolto nel corso della ricostruzione delle cause del dissesto.
Quello che il fallito dichiara al curatore, quando a lui sfavorevole, può per contro assumere un rilievo molto negativo e ciò sia per la mancanza di qualsiasi garanzia difensiva di tipo processual-penalistico, sia per il valore confessorio che la giurisprudenza gli attribuisce, sia, ancora, per il rilievo documentale che la stessa giurisprudenza attribuisce alla relazione del curatore.
Andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere per quale ragione il fallito deve pesare bene ogni parola detta al curatore e deve munirsi di una valida assistenza legale di tipo preventivo.
Innanzi tutto è da dire che, nonostante i tentativi reiterati delle difese e due sentenze della Consulta, la Cassazione è monolitica nel dire che le garanzie difensive del codice di procedura penale non si applicano alle dichiarazioni rese dal fallito agli organi della procedura. In sostanza, non vale in questa fase il principio secondo il quale, quando un soggetto, ascoltato dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, inizi a dire cose dalle quali emergono indizi di reaità a suo carico, occorre “interrompere il verbale” e invitarlo a munirsi di un difensore.
Le Procure, forti di questa monoliticità, stentano a iscrivere il fallito nel registro degli indagati e preferiscono, prima di farlo, che il curatore gli faccia fare una bella serie di dichiarazioni eventualmente autoincriminanti. Spesso i pubblici ministeri lo fanno addirittura impartendo al curatore specifiche direttive in ordine alle domande da porre. In sostanza utilizzano il curatore come loro “longa manus”, ben sapendo che nessun giudice sarà disposto a dire che il curatore è assimilabile alla polizia giudiziaria. E’ evidente che, in questa situazione, chi inizi a parlare col curatore senza aver prima consultato un avvocato esperto nel settore, o è un santo o è un kamikaze.
Tutto ciò, ove ve ne fosse ancora bisogno, è aggravato dal fatto che la relazione del curatore, la quale recepisce al suo interno la letterale trascrizione degli interrogatori del fallito, viene acquisita, senza indugio e nella sua integralità, al fascicolo del dibattimento penale, alla stregua di un qualsiasi altro documento. Inoltre il curatore nel corso del suo esame testimoniale viene ascoltato “de relato” su quanto a lui dichiarato dal fallito e da lui trasposto nella suddetta relazione, ex art. 33 legge fallimentare.
Fallito avvisato ….
Autore dell’articolo Enrico Leo – tutti i diritti riservati
Il giudice deve guardare negli occhi il testimone
Quando nel corso del dibattimento penale cambia la persona fisica che compone l’organo giudicante, i testi devono essere riascoltati dal nuovo giudice.
Si è fatto un gran parlare della necessità, a presunti fini di economia processuale, di evitare di riascoltare i testimoni davanti al nuovo organo giudicante, qualora mutino la persona o le persone fisiche che lo compongono.
Si assiste spesso a manifestazioni di fastidio da parte dei giudici quando gli avvocati, in simili ipotesi, chiedono di riascoltare i testimoni.
Si assiste spesso anche a prassi minimizzatrici del diritto in questione, nelle quali il giudice si limita a chiedere al teste riconvocato se conferma la dichiarazione resa davanti al precedente giudice.
Come se si trattasse di espletare un rito privo di senso pratico.
Come se il nuovo giudice non avesse alcun interesse ad adempiere con diligenza a quel dovere morale e professionale che gli impone di guardare il testimone negli occhi.
Come se il principio del libero convincimento nella formazione del giudizio, così di condanna, come di assoluzione, non gli imponesse di rendersi conto in via diretta dell’attendibilità della fonte.
Come se il linguaggio corporeo e tutto il corredo di sfumature che accompagnano le parole del dichiarante non avessero alcun valore comunicativo.
Per fortuna oggi interviene la sentenza delle Sezioni Unite penali (27620/2016), la quale, con grande autorevolezza, riporta al centro del processo penale alcuni concetti basilari, tratti dalla logica del rito accusatorio e dalla giurisprudenza europea sul diritto inalienabile ad un processo equo: oralità della prova, immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e dialettica delle parti nella sua formazione.
Ecco le parole della sentenza in punto di rapporto diretto fra giudice e testimone:
“Dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull’apprezzamento degli elementi di prova … “
Tale pronuncia utilizza poi proprio il canone dell’ immediatezza della formazione della prova dichiarativa davanti al giudice chiamato a decidere per stabilire che, qualora il giudice di appello intenda ribaltare una sentenza assolutoria emessa in primo grado, egli deve riascoltare i testimoni ogniqualvolta intenda fornire una diversa e antitetica interpretazione di quanto dagli stessi narrato.
Attenzione quindi a pretendere la rinnovazione dell’esame dei testimoni, la quale peraltro deve essere disposta anche d’ufficio, quando la sentenza che ha assolto l’imputato venga appellata dal Pubblico Ministero o dalla parte civile, invocando una diversa interpretazione delle risultanze delle prove orali.
Avv. Enrico Leo – tutti i diritti riservati